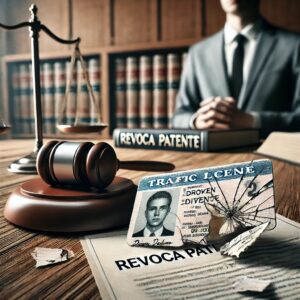Che cos’è una sanzione penale?
La “sanzione penale” può essere descritta come una misura punitiva imposta dallo Stato in seguito alla commissione di un reato. Tale misura ha lo scopo di reprimere e prevenire comportamenti illeciti, garantendo così la tutela dell’ordine sociale e della convivenza pacifica. La sua applicazione è subordinata ai principi di legalità, proporzionalità e umanità, al fine di garantire la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.Il giudice, dopo aver accertato che un fatto concreto soddisfa i criteri previsti dalla legge, a conclusione di un processo penale, accerta la colpevolezza di un soggetto reo, ne dichiara la colpevolezza, pronuncia la condanna ed infligge ad esso una pena.La finalità della pena nel sistema penale italiano è duplice: da un lato, mira a retribuire il colpevole per il suo comportamento criminale, in conformità con il principio della giustizia riparativa; dall’altro, si propone di prevenire la commissione di ulteriori reati attraverso la generalità e la speciale capacità dissuasiva delle sanzioni penali.
Una panoramica delle sanzioni penali
L’articolo 17 del Codice Penale : la classificazione delle pene principali, seguendo il principio nominalistico sancito dall’articolo 17 del Codice Penale, si basa sulla distinzione tra “contravvenzioni” e “delitti”.
“Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) la morte;
2) l’ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l’arresto;
2) l’ammenda.”
L’evoluzione del concetto di pena nell’ordinamento italiano
La classificazione delle sanzioni penali ha subito un’evoluzione storica che ha portato alla prevalenza della teoria special preventiva rispetto alla teoria retributiva.
In passato, la sanzione penale era concepita principalmente come una “pena” intesa a retribuire il colpevole per il suo comportamento criminale. La teoria retributiva sosteneva che la punizione dovesse essere proporzionata alla gravità del reato commesso, con l’obiettivo di ripristinare un equilibrio morale violato dall’azione delittuosa.Tuttavia, con il passare del tempo, si è sviluppata una nuova concezione della sanzione penale, in cui la sua finalità si è spostata verso una prospettiva più orientata alla prevenzione del reato. Questo approccio, noto come teoria special preventiva, si concentra sulla protezione della società e sulla prevenzione della recidiva attraverso l’applicazione di misure rieducative, di sicurezza e di controllo.
La teoria special preventiva pone l’accento sull’obiettivo di prevenire futuri reati e di ridurre il pericolo che un individuo rappresenta per la società. Le sanzioni penali vengono quindi utilizzate quale deterrente per impedire che il condannato possa commettere ulteriori reati e per garantire la sua riabilitazione e reinserimento sociale.
Questa evoluzione storica ha determinato un cambiamento nella concezione delle sanzioni penali, passando da una visione prevalentemente retributiva a una maggiormente orientata alla prevenzione e alla rieducazione. L’obiettivo principale delle sanzioni penali è diventato quello di proteggere la società, prevenire il crimine e favorire la rieducazione del colpevole, abbandonando gradualmente l’idea di una punizione basata esclusivamente sulla retribuzione morale del reato commesso.
Le sanzioni sono la risposta dello Stato a un determinato comportamento giuridicamente rilevante. Una sanzione può essere penale, amministrativa, civile, o di altro tipo. La pena rientra nel più ampio genus delle “sanzioni”, ma come si distingue dalle altre sanzioni?
La pena come sofferenza: una definizione obsoleta?
Il sistema delle sanzioni penali è notevolmente evoluto nel corso dei secoli. Da un sistema che privilegiava pene severe e corporali, si è passati a un sistema in cui la pena detentiva ha gradualmente guadagnato spazio, fino all’abolizione totale della pena di morte in molti paesi.
Spesso nei manuali si trova scritto che la pena è una sofferenza, ovverosia un male inflitto all’autore di un reato. Questa definizione potrebbe aver avuto senso nei tempi in cui la sanzione principale era la galera, la morte o la tortura. Ma oggi, in un sistema in cui le pene possono essere le più varie, senza sempre tradursi in sofferenze, la pena non può più essere definita come tale.
Il carcere, tuttavia, conserva ancora un ruolo centrale negli ordinamenti penali, nonostante sia sempre più percepito come un luogo di degrado e non di riabilitazione del condannato essendo considerato l'”extrema ratio”, cioè l’ultima risorsa, nel contesto dell’applicazione della pena della reclusione.
L’istituto penitenziario è una struttura governativa destinata all’esecuzione delle pene privative della libertà personale, come la reclusione. La sua funzione principale è quella di custodire e rieducare gli individui condannati per reati gravi, offrendo al contempo un ambiente sicuro e controllato per la tutela della società.
La pena della reclusione, che rappresenta la privazione della libertà personale, viene applicata ai soggetti riconosciuti colpevoli di reati di particolare gravità, in conformità con i principi di legalità e proporzionalità. L’istituto penitenziario viene quindi considerato l’extrema ratio, ovvero l’ultima misura di intervento dello Stato, utilizzata quando altre forme di sanzioni non sono ritenute sufficienti o adeguate per garantire la sicurezza e il controllo del condannato.
L’istituto penitenziario, oltre a garantire la detenzione del condannato, svolge un ruolo importante nella rieducazione e nella riabilitazione sociale. Attraverso programmi e attività volte a favorire la reintegrazione del condannato nella società, l’istituto penitenziario mira a ridurre la recidiva e a fornire al detenuto le opportunità necessarie per un cambiamento positivo del comportamento.
Evoluzione del concetto di pena
Il sistema delle sanzioni penali, come anticipato, è notevolmente evoluto nel corso dei secoli. Da un sistema che privilegiava pene severe e corporali, si è passati a un sistema in cui la pena detentiva ha gradualmente guadagnato spazio, fino all’abolizione totale della pena di morte in molti paesi.
Una definizione moderna di pena
La pena consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale. Sotto il profilo del contenuto, questa definizione può dirsi soddisfacente, eliminando l’erronea equiparazione della pena alla sofferenza.
La Costituzione italiana all’art. 27 rstabilisce che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato“.
Dunque le pene, nell’ordinamento italiano, devono rispettare il senso di umanità e tendere alla rieducazione del condannato. Questo articolo sancisce due principi fondamentali:
- il principio di umanità della pena, che impedisce l’introduzione di pene lesive del rispetto della persona;
- ed il principio della finalità rieducativa della pena, secondo cui le pene non devono essere orientate solo alla punizione, ma principalmente alla rieducazione del condannato.
La rieducazione è quindi l’obiettivo primario della pena, e lo Stato ha il compito di favorire le condizioni necessarie per il reinserimento del condannato nella società.
Quali sono i tipi di sanzioni penali?
I tipi di sanzioni penali previste dal nostro ordinamento sono, per i delitti, l’ergastolo, la reclusione, la multa e, per le contravvenzioni, l’arresto e l’ammenda.
Oltre a queste, sono previste pene accessorie che normalmente conseguono di diritto dalla condanna, tra cui l’interdizione da una professione o arte, la sospensione dall’esercizio da una professione o arte, la pubblicazione della sentenza penale di condanna, la sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pene accessorie e misura della pena
Il codice penale stabilisce anche delle pene accessorie, che complementano ma non sostituiscono le pene principali. Queste possono includere l’interdizione dai pubblici uffici o dall’esercizio di una professione.
Solo il giudice (o magistrato) in quanto rappresentante e custode dell’autorità statuale nel contesto decisionale, ha il potere di accertare la responsabilità penale in capo all’imputato, applicare e fare imporre le sanzioni penali al condannato. Inoltre la determinazione della pena è un processo che implica una valutazione discrezionale, basata su parametri stabiliti dalla legge.
Per determinare la misura della pena, il magistrato deve considerare le circostanze e la gravità complessiva del reato, come stabilito dall’art. 133 del codice penale.
Elementi considerati nella determinazione e misurazione della pena
Nella determinazione della pena, diversi elementi vengono presi in considerazione. Tra questi ci sono:
- la natura del reato
- la specie di reato
- i mezzi usati dall’imputato
- l’oggetto del reato
- il tempo e il luogo del reato
- la gravità del danno o del pericolo causato alla vittima
- intensità del dolo o del grado della colpa
- la capacità a delinquere
- il carattere del reo
- i precedenti penali e giudiziali dell’imputato
- la condotta del reo contemporanea e successiva al reato
- la vita del reo precedenti al fatto
- le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Teorie della pena: retributiva, generale preventiva, speciale preventiva
La questione fondamentale rimane: quali sono gli scopi che giustificano la privazione della libertà personale imposta dallo Stato? La risposta può essere trovata nelle teorie della pena, che si riconducono principalmente a tre filoni.
1. La teoria retributiva della pena
La teoria retributiva sostiene che la pena debba essere comminata come risposta diretta al reato commesso, in modo da ripristinare un equilibrio morale violato dall’azione delittuosa. Questo principio trova le sue radici nella legge del taglione, che prevedeva una risposta proporzionata al danno causato dall’offesa.
Secondo la teoria retributiva, il colpevole deve subire una pena che sia commisurata alla gravità del reato commesso, senza alcuna considerazione per scopi preventivi o rieducativi. La pena viene concepita come una sorta di “giusta punizione” che soddisfa il senso di giustizia e di vendetta sociale.
Esempi storici che riflettono l’applicazione della teoria retributiva possono includere il sistema di giustizia criminale medievale, in cui venivano applicate pene come la tortura o la pena di morte come risposta proporzionata al reato commesso.
Tuttavia, la teoria retributiva è stata oggetto di critica e dibattito nel corso del tempo. Molti studiosi e giuristi hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’effettiva efficacia della retribuzione come principio guida nella determinazione delle pene, sottolineando la necessità di considerare anche obiettivi di prevenzione, rieducazione e reinserimento sociale nel sistema penale.
2. La teoria general preventiva della pena
Le teorie preventive, al contrario, sono focalizzate sugli effetti della pena. La teoria generale preventiva sostiene che la pena debba essere finalizzata principalmente alla prevenzione del reato, con l’obiettivo di scoraggiare sia il condannato che potenziali futuri delinquenti dall’incorrere in comportamenti criminali. Questa teoria si concentra sulla tutela della società nel suo complesso e mira a creare un clima di rispetto per la legge e a ridurre l’incidenza dei reati.
Esempi storici che riflettono l’applicazione della teoria generale preventiva possono includere l’introduzione di pene severe per i reati violenti o la criminalità organizzata, con l’obiettivo di dissuadere gli individui dal commettere tali atti per timore delle conseguenze. Inoltre, autori quali Cesare Beccaria, nel suo lavoro rivoluzionario “Dei delitti e delle pene”, hanno sostenuto l’importanza di una pena proporzionata e certa come mezzo per prevenire la commissione di reati.
La teoria generale preventiva si basa sulla convinzione che la certezza e la severità delle pene possano avere un effetto deterrente sulla commissione dei reati.
3. La teoria special preventiva della pena : rieducazione, risocializzazione, neutralizzazione
La teoria special preventiva sostiene che la pena debba essere finalizzata principalmente alla prevenzione speciale del reato, concentrandosi sul singolo individuo condannato. Questo approccio si basa sulla convinzione che attraverso misure di rieducazione, risocializzazione, neutralizzazione sia possibile ridurre il rischio che il condannato commetta nuovi reati e favorire il suo reinserimento nella società.
La teoria special preventiva si basa sui principi :
- di rieducazione si concentra sulla trasformazione del comportamento criminale attraverso programmi di trattamento e interventi che mirano a modificare gli atteggiamenti, le abitudini e le motivazioni del condannato. Questo aspetto sottolinea l’importanza di fornire al condannato strumenti per affrontare le cause profonde del reato e sviluppare una visione positiva della vita senza ricorrere a comportamenti criminali.
- di risocializzazione che, invece, mira a favorire la reintegrazione sociale del condannato, offrendo opportunità di formazione, lavoro, assistenza psicologica e supporto sociale. Questo aspetto sottolinea l’importanza di fornire al condannato le risorse e le competenze necessarie per una vita autonoma e responsabile dopo il periodo di detenzione.
- di neutralizzazione che implica l’adozione di misure atte a rimuovere o ridurre la pericolosità del condannato, al fine di proteggere la società. Ciò può comportare la privazione della libertà personale attraverso la detenzione o l’applicazione di restrizioni specifiche, come la sorveglianza speciale.
Infine, la teoria speciale preventiva vede la pena come un mezzo per prevenire la commissione di ulteriori reati da parte del condannato.Tuttavia, queste teorie non forniscono una risposta definitiva alla questione fondamentale della pena, in quanto sono fortemente influenzate dal quadro costituzionale di ciascun paese in un dato momento storico.
Fonti Normative
Le leggi che regolano questi concetti si trovano principalmente nel codice penale e nel codice di procedura penale. Queste normative coprono una vasta gamma di aspetti, da definizioni di termini e concetti fondamentali, ai processi di indagine, di udienza preliminare e alla tipologia dei reati.
Conclusione
L’assistenza di uno studio legale penale specializzato è fondamentale per affiancare l’imputato nel corso del procedimento giudiziale penale.
Contatta l’Avvocato Abbondanza del foro di Milano per una consulenza sul tuo caso e per avere supporto giudiziario in ogni fase di giudizio penale.